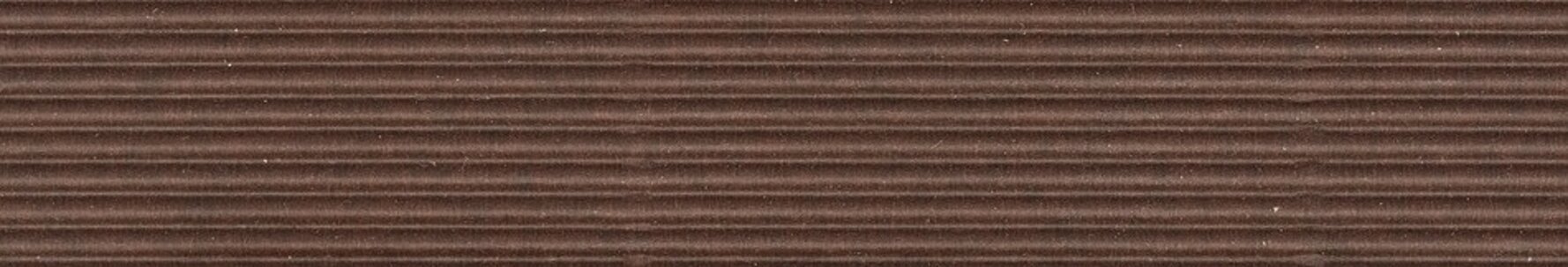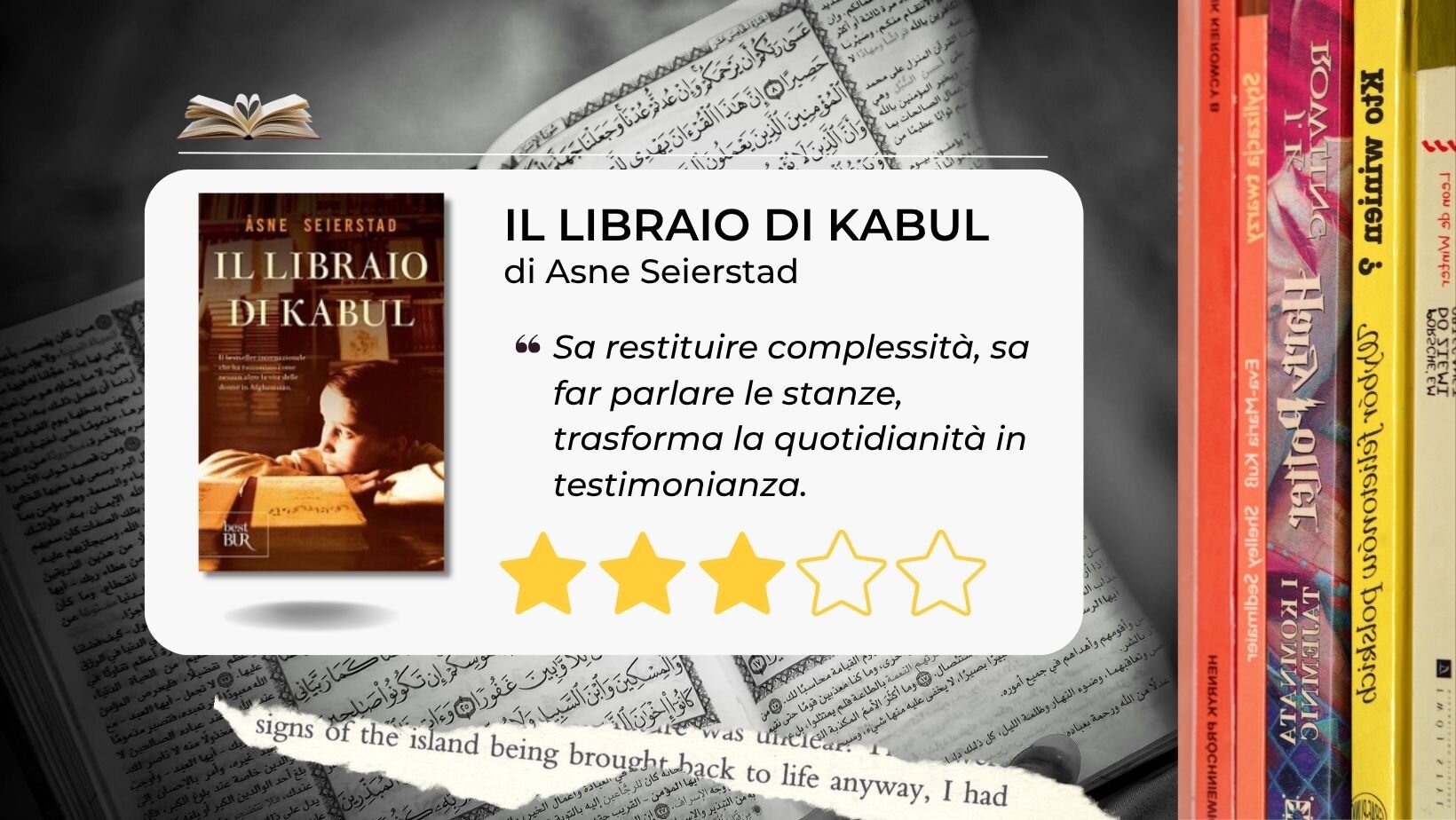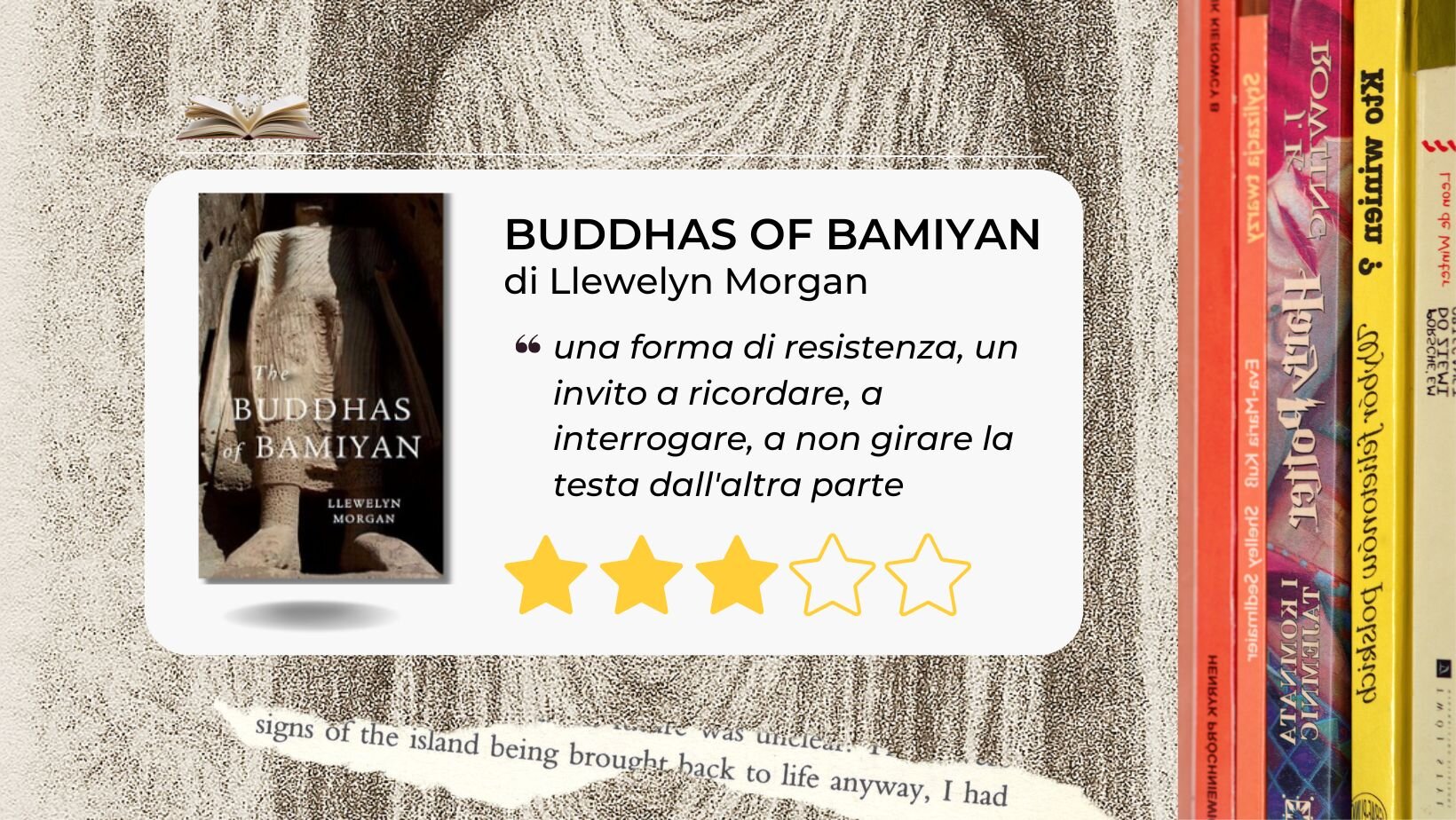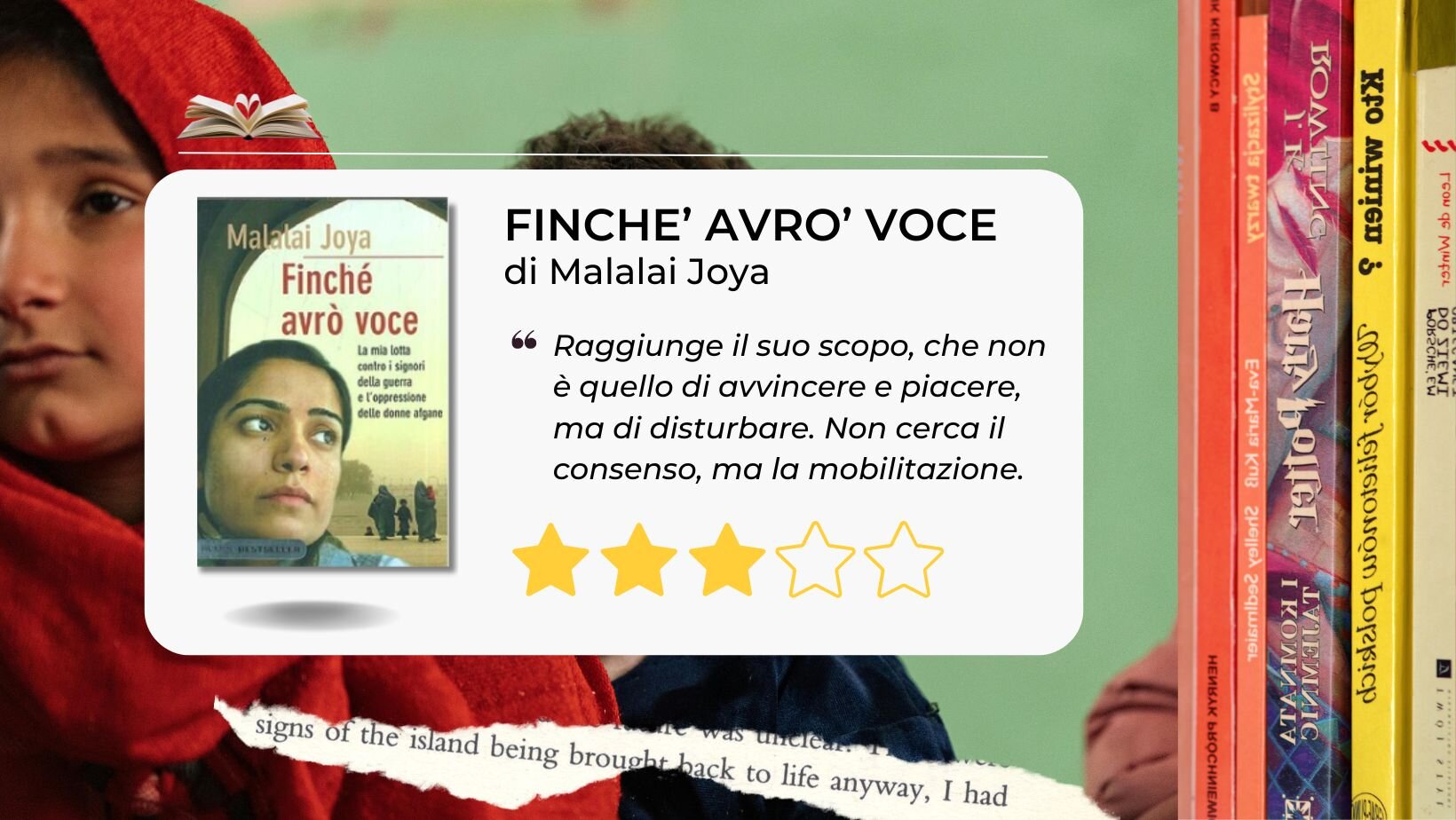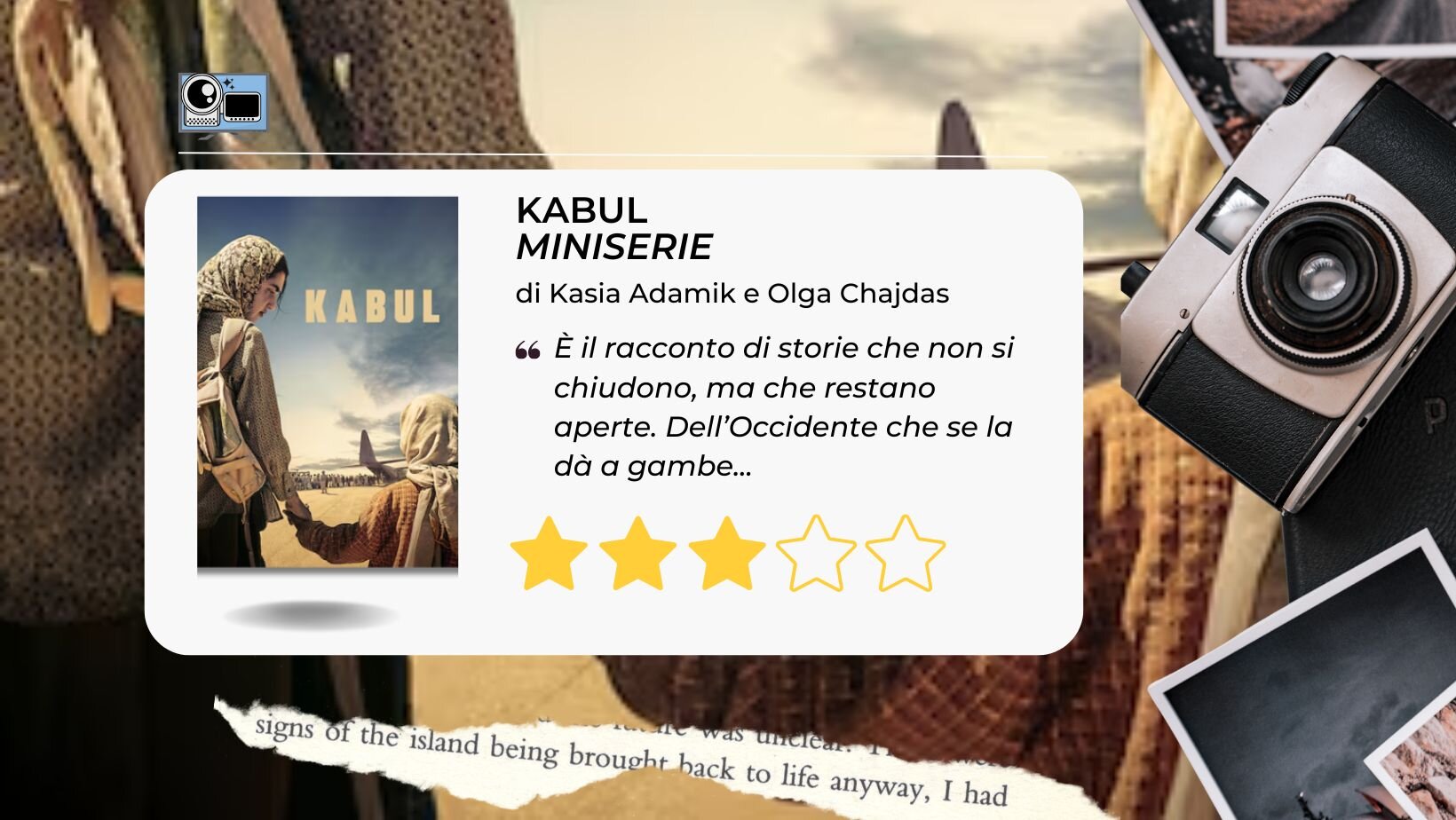Avvertenza
Valutazione e recensione sono frutto del mio personale gusto individuale, delle mie preferenze letterarie, così come la valutazione che assegno. E' quindi più che comprensibile, anzi auspicabile, che molti non la pensino come me. Detto ciò: ogni libro è fatto per essere letto.
⭐ Sufficiente
⭐ ⭐ Più che discreto
⭐ ⭐ ⭐ Buono
⭐ ⭐ ⭐ ⭐ Ottimo
⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ Eccellente
La mia valutazione su questo libro:
⭐ ⭐ ⭐ Buono
In un mondo che brucia i libri, Sultan Khan li vende. Li archivia, li protegge, li impila come mattoni di una casa che non crolla. In un’epoca in cui la parola scritta è sospetta, censurata, perseguitata, lui la espone in vetrina. Il libraio di Kabul, reportage narrativo della giornalista norvegese Åsne Seierstad, è il ritratto di un uomo che sfida il rogo con lo scaffale, e di una famiglia che vive sotto lo stesso tetto della carta, ma non sempre ne respira la libertà.
Siamo a Kabul, 2001. I talebani sono appena stati rovesciati, ma la loro ombra è lunga, sedimentata nei muri, nei silenzi, nei gesti. Sultan Khan — nome di fantasia per proteggere l’identità reale, anche se da più parti ormai se ne cita il nome in Shah Muhammad Rais — è un libraio colto, ostinato, autoritario. Ha passato anni a salvare libri proibiti, a nasconderli sotto il pavimento, a rischiare la prigione per un verso di poesia. La sua libreria è la più fornita della città, un’arca di carta in un mare di macerie. Ma è anche un luogo ambiguo, dove la cultura non sempre coincide con l’emancipazione, e dove la libertà si ferma sulla soglia di casa. Seierstad entra in questa casa come ospite, ma scrive come testimone. Vive con la famiglia di Sultan per diversi mesi, osserva, ascolta, annota. Il risultato è un libro che si legge come romanzo, pur vestendo talvolta i panni di un saggio. Nonostante tutto non è ne l'uno ne l'altro: è un diario in terza persona, un reportage intimo, un atto di disvelamento. Ogni capitolo è un frammento di vita: la seconda moglie adolescente, la sorella frustrata, il figlio che sogna l’Occidente, la madre che prega. E sopra tutti, Sultan, il patriarca che ama i libri ma detta legge, che sfida i talebani ma riproduce il controllo tra le mura domestiche.
È qui che la tensione si fa più acuta. Perché Il libraio di Kabul non è l’agiografia di un eroe culturale, ma il ritratto di un uomo complesso, contraddittorio. Sultan è al tempo stesso custode e carceriere, illuminato e dispotico. Ama la letteratura, ma non tollera la disobbedienza. Difende i libri, ma non sempre le persone. La sua libreria è un baluardo contro l’oscurantismo, ma anche il centro di un microcosmo patriarcale che riproduce, in scala domestica, le stesse dinamiche di potere che i talebani hanno imposto su scala nazionale. Eppure, proprio in questa ambivalenza, il libro trova la sua forza. Perché ci costringe a uscire dalla semplificazione, a guardare l’Afghanistan non come teatro esotico di barbarie o redenzione, ma come spazio reale, abitato da persone reali, con desideri, paure, contraddizioni. Seierstad si impegne nello scrivere: si astiene da offrire giudizi sommari, ma nemmeno assolve. Mostra. E nel mostrare, interroga.
Il paragone con Fahrenheit 451 di Ray Bradbury non è solo suggestivo: è strutturale. Là dove Bradbury immaginava un futuro in cui i pompieri bruciavano i libri per legge, qui assistiamo a un presente in cui i talebani li bruciano per dogma. Là dove Montag, il protagonista di Fahrenheit, scopre la lettura come atto di liberazione, qui Sultan la pratica come atto di conservazione. Ma c’è una differenza cruciale: nel mondo di Bradbury, i libri sono vietati perché pericolosi; in quello di Sultan, sono tollerati solo se non mettono in discussione l’ordine familiare. La censura non è solo esterna, è anche interna. Non è solo il regime a temere la parola: è anche il padre, il marito, il fratello.
E allora la libreria di Kabul diventa un luogo simbolico, un crocevia tra resistenza e controllo. È Fahrenheit 451 rovesciato: non più il fuoco che distrugge, ma la carta che non libera. Non più la distopia tecnologica, ma la distopia patriarcale. Eppure, in mezzo a questa tensione, i libri restano. Resistono. Come la sorella di Sultan, Leila, che sogna di studiare. Come la giovane Sonya, che legge di nascosto. Come la stessa Seierstad, che scrive. Il libro ha suscitato polemiche, soprattutto per la sua rappresentazione della famiglia afghana. Sultan ha intentato causa, accusando l’autrice di aver violato la sua privacy e distorto i fatti. Ma al di là della controversia legale, resta il valore documentario e narrativo dell’opera: la capacità di restituire complessità, di far parlare le stanze, di trasformare la quotidianità in testimonianza.
La scrittura è asciutta, precisa, scandinava. Seierstad non cerca l’effetto, ma l’osservazione. Non costruisce eroi, ma persone. E in questo sta la sua forza: nel raccontare l’Afghanistan non come sfondo, ma come protagonista. Non come eccezione, ma come specchio. Alla fine della lettura, resta una domanda: cosa significa davvero salvare un libro? È sufficiente conservarlo, o bisogna anche viverlo? Sultan Khan ha salvato migliaia di volumi, ma ha permesso che le donne della sua casa restassero analfabete di libertà. È un eroe culturale o un despota domestico? Un Montag afghano o un pompiere travestito da libraio? La risposta non è univoca. Ma forse è proprio questa ambiguità a rendere il libro necessario. Perché ci ricorda che la cultura non è mai neutra, e che ogni scaffale è anche una scelta politica. Perché ci mostra che i libri possono essere rifugio o prigione, specchio o maschera. E perché, in un mondo che ancora brucia le parole, leggere resta un atto radicale.