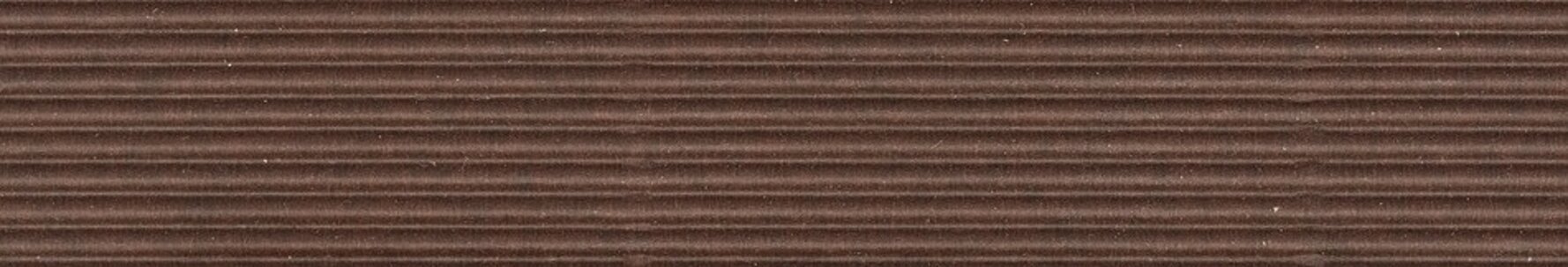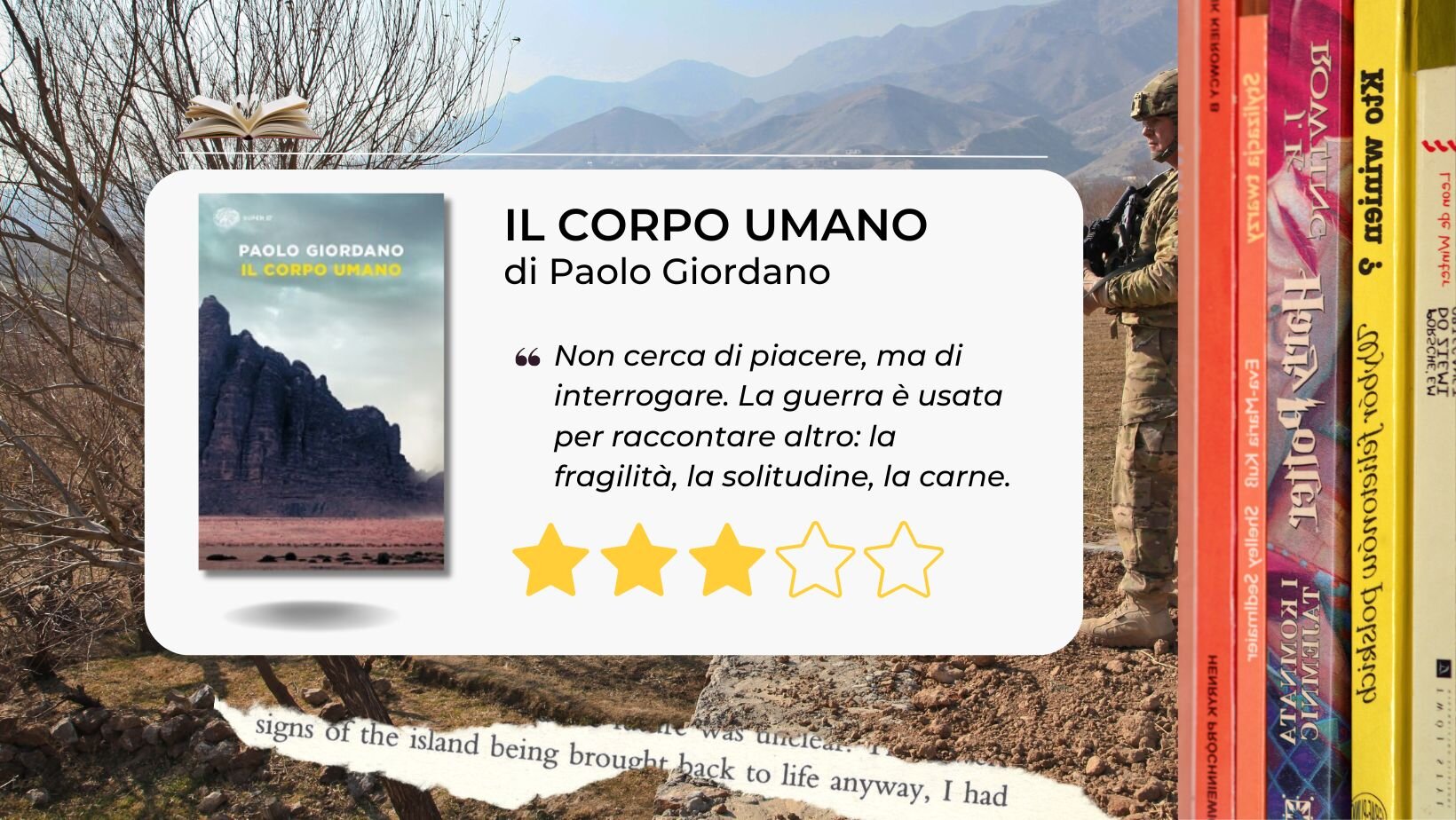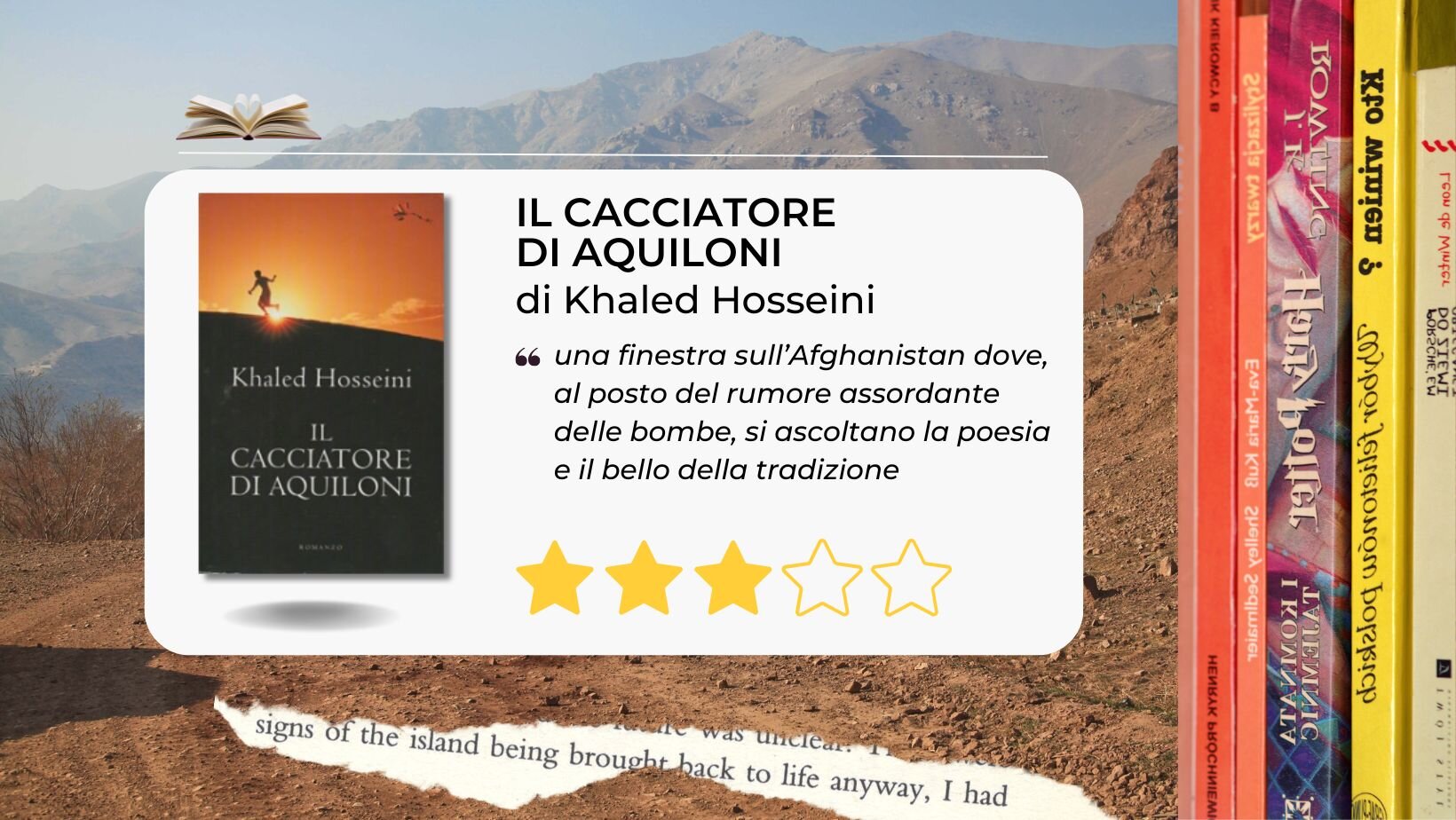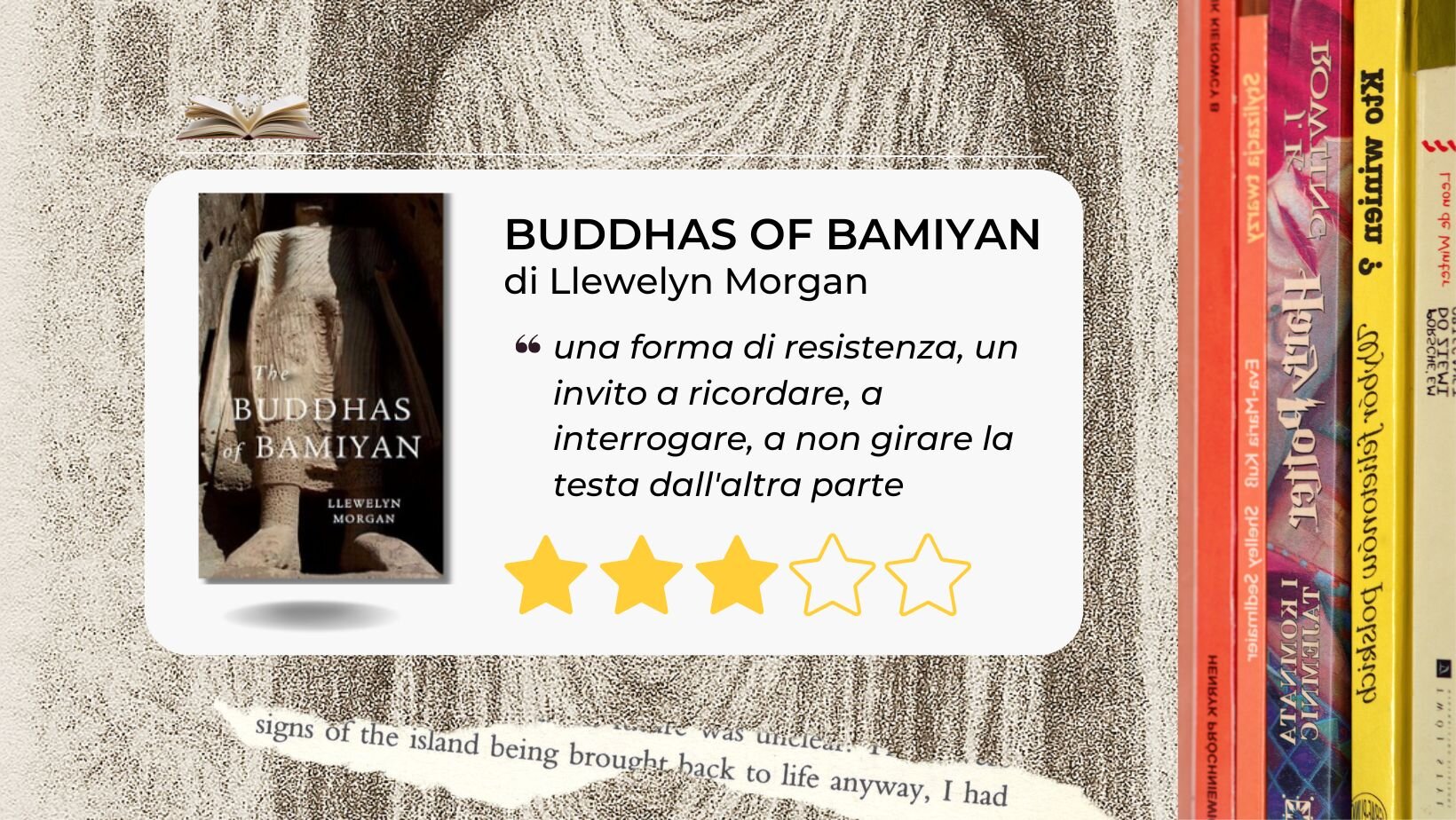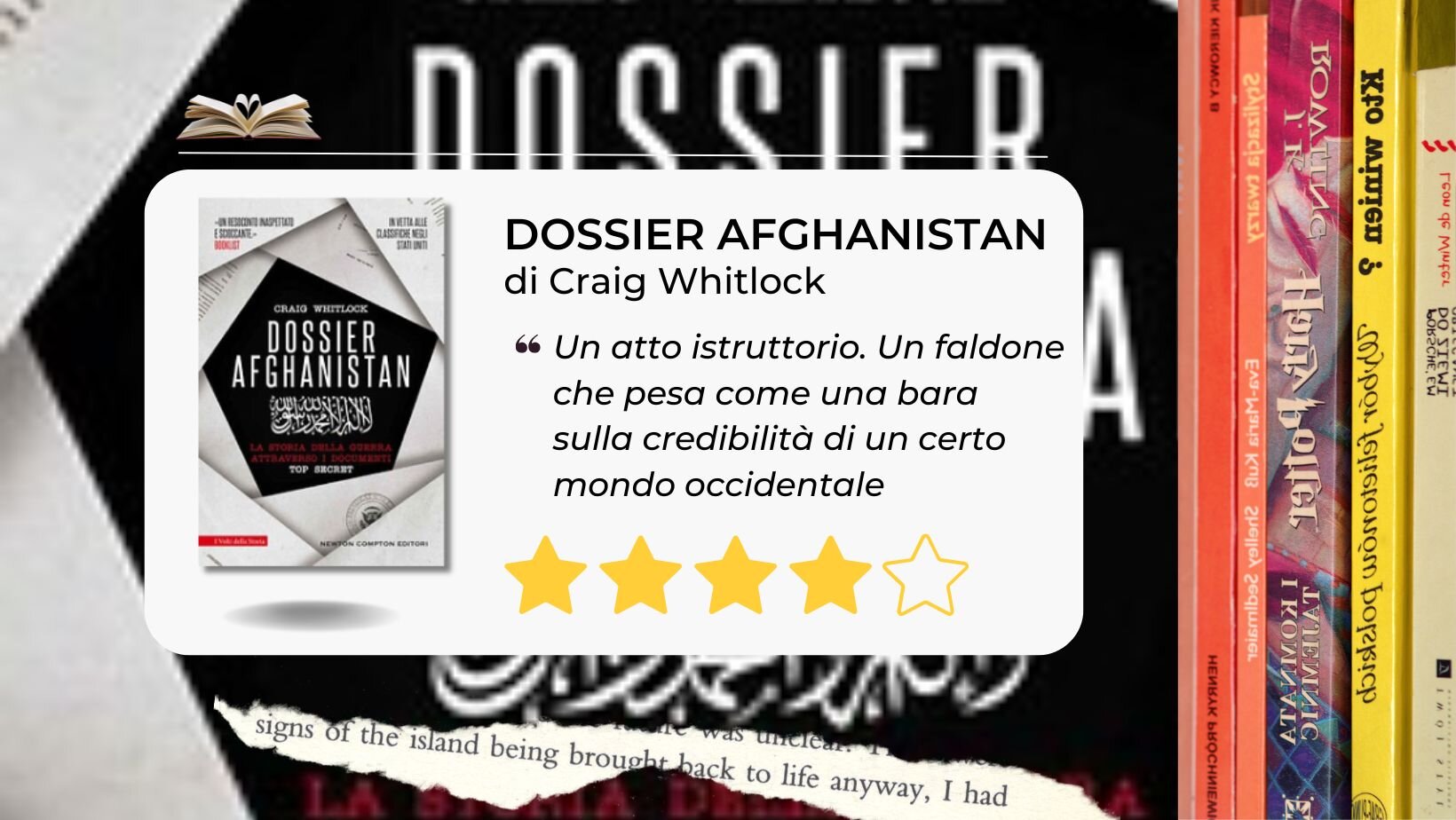Avvertenza
Valutazione e recensione sono frutto del mio personale gusto individuale, delle mie preferenze letterarie, così come la valutazione che assegno. E' quindi più che comprensibile, anzi auspicabile, che molti non la pensino come me. Detto ciò: ogni libro è fatto per essere letto.
⭐ Sufficiente
⭐ ⭐ Più che discreto
⭐ ⭐ ⭐ Buono
⭐ ⭐ ⭐ ⭐ Ottimo
⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ Eccellente
La mia valutazione su questo libro:
⭐ ⭐ ⭐ Buono
Ci sono romanzi che, pur stando dentro una guerra, non la raccontano in quanto tale, ma la usano come pretesto per ingrandire le crepe dell’essere umano. Il corpo umano di Paolo Giordano è uno di questi. Non è un romanzo di guerra, eppure la guerra è ovunque. Non è un romanzo politico, eppure ogni pagina è attraversata da una domanda civile. Non è un romanzo corale, eppure ogni voce che lo abita è parte di un’eco più grande, dissonante, che ci riguarda. È un libro che non cerca di spiegare, ma di esporre. E lo fa con una scrittura che taglia come un bisturi, come una sonda che s’insinua nell’abisso dell’animo umano.
Il titolo è già una dichiarazione: Il corpo umano. Non l’Afghanistan, non la missione italiana all’estero, non la patria. Il corpo. Quello dei soldati, dei medici, dei giovani mandati in divisa a presidiare un altrove che, i più, davvero non comprendono. Il corpo come luogo del trauma, come spazio della paura, come soglia tra il dentro e il fuori. Giordano, con la sua formazione da fisico e la sua vocazione da narratore, abbandona le metafore cosmiche del suo esordio per entrare ora in un microcosmo che è quello della carne, della fisiologia del dolore, della biologia della fragilità. Il corpo umano è sezionato, esposto, interrogato. E in questo, il romanzo è chirurgico. Ma anche profondamente umano. E qui sta la sensibilità di un autore che conosciamo ancora poco.
Non c’è un protagonista solista, ma una costellazione di personaggi. Il maresciallo René – già gigolò e spogliarellista, “due volte in Libano, poi il Kosovo” –, il giovane Ietri che sulle spalle sopporta il peso di strati di insoddisfazione, il medico Zandano, il tenente Egitto, che anestetizza i suoi conflitti privati con gli psicofarmaci. Ognuno porta una ferita, una domanda, un’assenza. Non si fondono, non si completano. Si sfiorano, si urtano, talvolta si ignorano. Sono particelle di un sistema più complesso, dove la coralità non è necessariamente armonia, ma può diventare frammentazione. E in questo, il romanzo è specchio di una generazione: quella che è cresciuta senza guerra ma che la guerra l’ha incontrata, improvvisa, burocratica, lontana eppure vicinissima. Una generazione che non ha scelto, ma ha eseguito – per parafrasare il gergo militare. Che non ha creduto, ma ha obbedito. Che non ha capito, ma ha subito.
L’Afghanistan è presente, ma non raccontato. Siamo all’imbocco della valle del Gulistan, uno dei distretti della provincia meridionale afghana di Farah. Eppure non ci sono mappe, né analisi geopolitiche. Non ci sono talebani, né strategie militari. C’è il deserto, c’è la base militare “Ice”, c’è l’attesa. La guerra è un grande fondale, non è la trama. È il contesto che permette ai personaggi di rivelarsi, di crollare, di esporsi. Giordano non vuole spiegare la guerra: vuole mostrare cosa fa ai corpi, alle menti, alle relazioni, alla coscienza. E in questo, il romanzo è decisamente anti-epico. Leggendolo non si scorgono tra le pagine eroi, e tantomeno martiri. Persino il sacrificio di Roberto Ietri assomiglia più a un atto virile che a un immolarsi per la Patria. Quale patria, poi – se non quella che si dissolve tra le sabbie e le ambiguità della missione?
La guerra, in questo romanzo, assume la forma di un varco: non tanto un evento storico, quanto un dispositivo narrativo che traghetta i personaggi da una stagione all’altra della vita. È il catalizzatore che rende visibile ciò che altrimenti resterebbe indistinto, che dà spessore a esistenze altrimenti sospese in una giovinezza opaca, priva di contorni. Ma proprio in questa funzione simbolica si annida anche la fragilità dell’impianto: l’attentato, più che emergere come frattura reale, sembra talvolta agire come scorciatoia drammaturgica, come meccanismo per accelerare la maturazione dei protagonisti. In senso più ampio, l’ambientazione bellica rischia di diventare un alibi narrativo: un contesto estremo che giustifica, o addirittura nobilita, disfunzioni emotive e relazionali che altrove sarebbero rimaste irrisolte.
Il tempo è come sospeso. Cristallizzato nel posto di osservazione. Non c’è progressione, ma un ristagno in cui le lancette sembrano rallentare sino a fermarsi. I giorni si ripetono, le azioni si svuotano, le parole si consumano. Qui ci sono ragazzi che si masturbano, che si feriscono, che si odiano, uomini e donne che si amano male. C’è un’umanità che odora di sudore, e la gloria si è scolorita come un tessuto logoro, lavato troppe volte senza cura. La missione non è avventura, ma è attesa. E l’attesa logora, talvolta più dell’azione. E in questa attesa, i personaggi si deformano. Il presente è una bolla, il passato è un peso, il futuro è un’ipotesi. E in questo, il romanzo è claustrofobico. Non c’è via d’uscita, solo un lento scivolare verso qualcosa che non ha nome.
La scrittura è precisa, fredda, lucida. Non cerca l’effetto, né la commozione. È una lingua che osserva, che espone, che seziona. Ma proprio per questo, è anche compassionevole. Non c’è retorica, né indulgenza. C’è una distanza che non è cinismo, ma pudore. Giordano non giudica, non assolve, non condanna. Lascia che siano i corpi a parlare. E i corpi parlano. Con le loro ferite, con le loro secrezioni, con i loro silenzi. Il dolore non è spiegato, è mostrato. E in questo, il romanzo somiglia all’Afghanistan stesso: ferito, resistente, indecifrabile.
L’italianità è presente, ma non celebrata. I soldati – lo ribadisco – non sono raccontati come eroi, né come vittime. Sono ragazzi, sono corpi, sono le loro domande, sono quello che sono. L’italianità non è bandiera, ma dubbio. È la domanda su cosa ci facciamo lì, su cosa portiamo, su cosa lasciamo. E tutto questo domandare, in ognuno dei personaggi, crea una certa tensione etica, un’inquietudine civile. E in questo, il romanzo è “politico”, ma senza proclami urlati. Non si riassume in una presa di posizione, ma espone le conseguenze. E le conseguenze sono tutte nei corpi: quelli che tornano, quelli che restano, quelli che non si ricompongono più. Perché quando il Lince guidato da Salvatore Camporesi salta in aria su venti chili di esplosivo, i passeggeri si dilaniano. Tutti, eccetto uno.
Proprio perché non perfetto, proprio perché non esaustivo, è profondamente umano. È un libro che, sin dalle prime righe, non cerca di piacere, ma di interrogare. La guerra è usata per raccontare altro: la fragilità, la solitudine, la carne. E in questo, è profondamente italiano. Non per il passaporto dei personaggi, ma per quella capacità tutta nostra di trasformare la cronaca in memoria, la distanza in domanda.