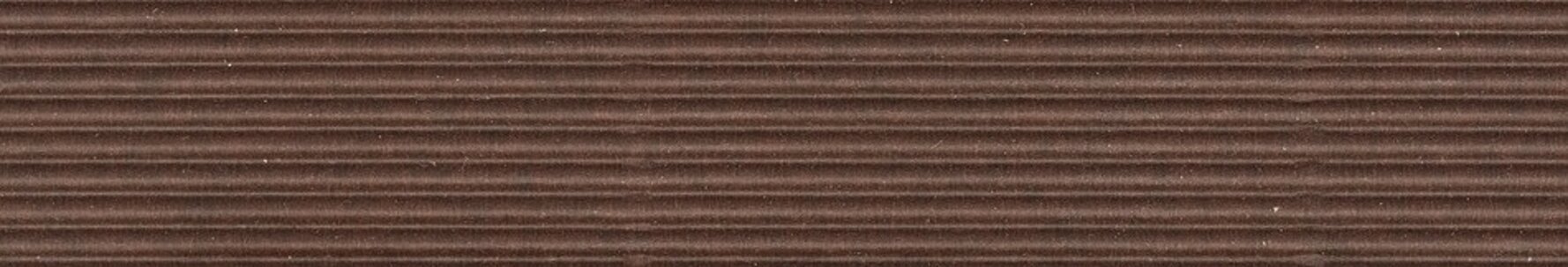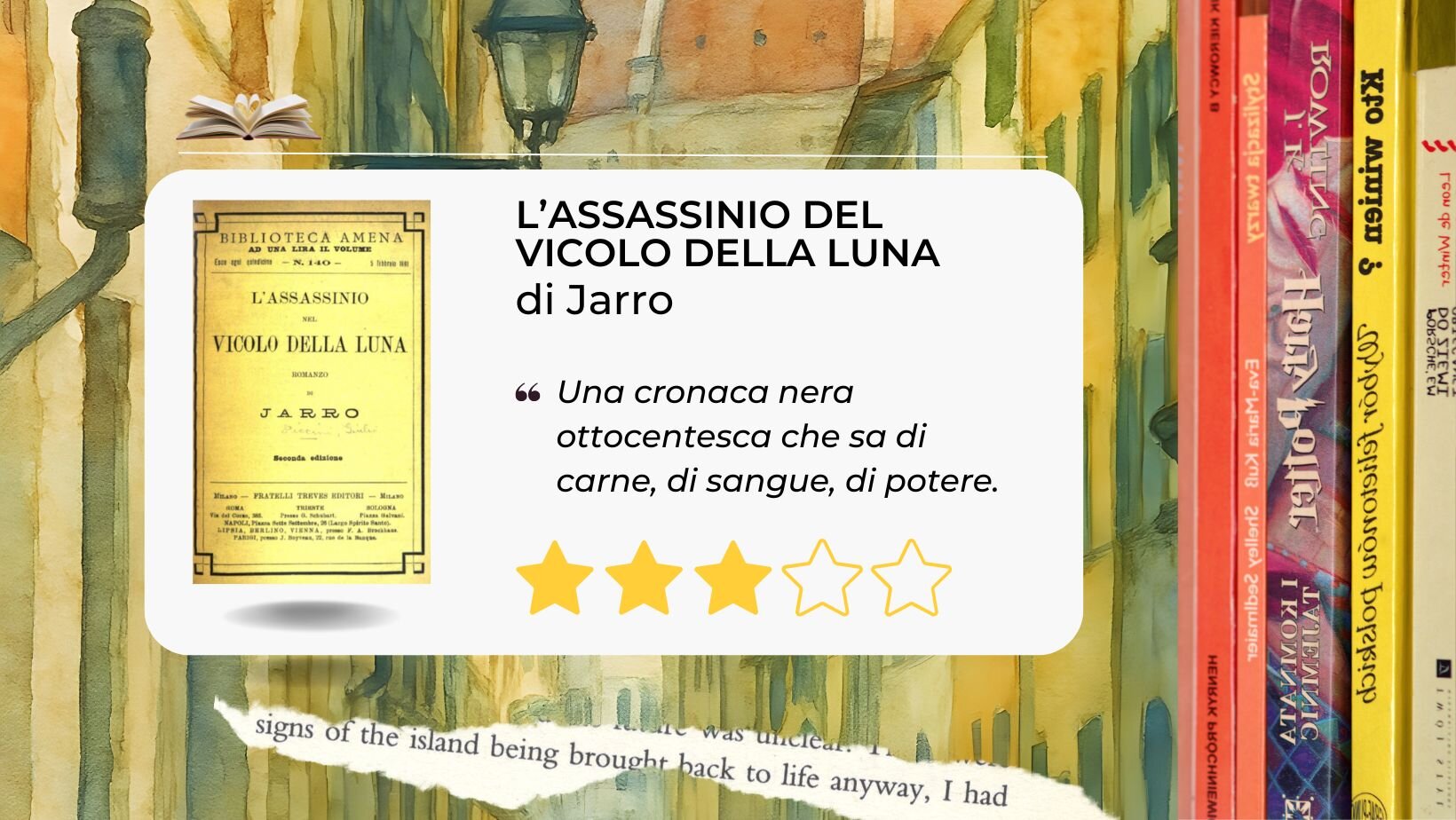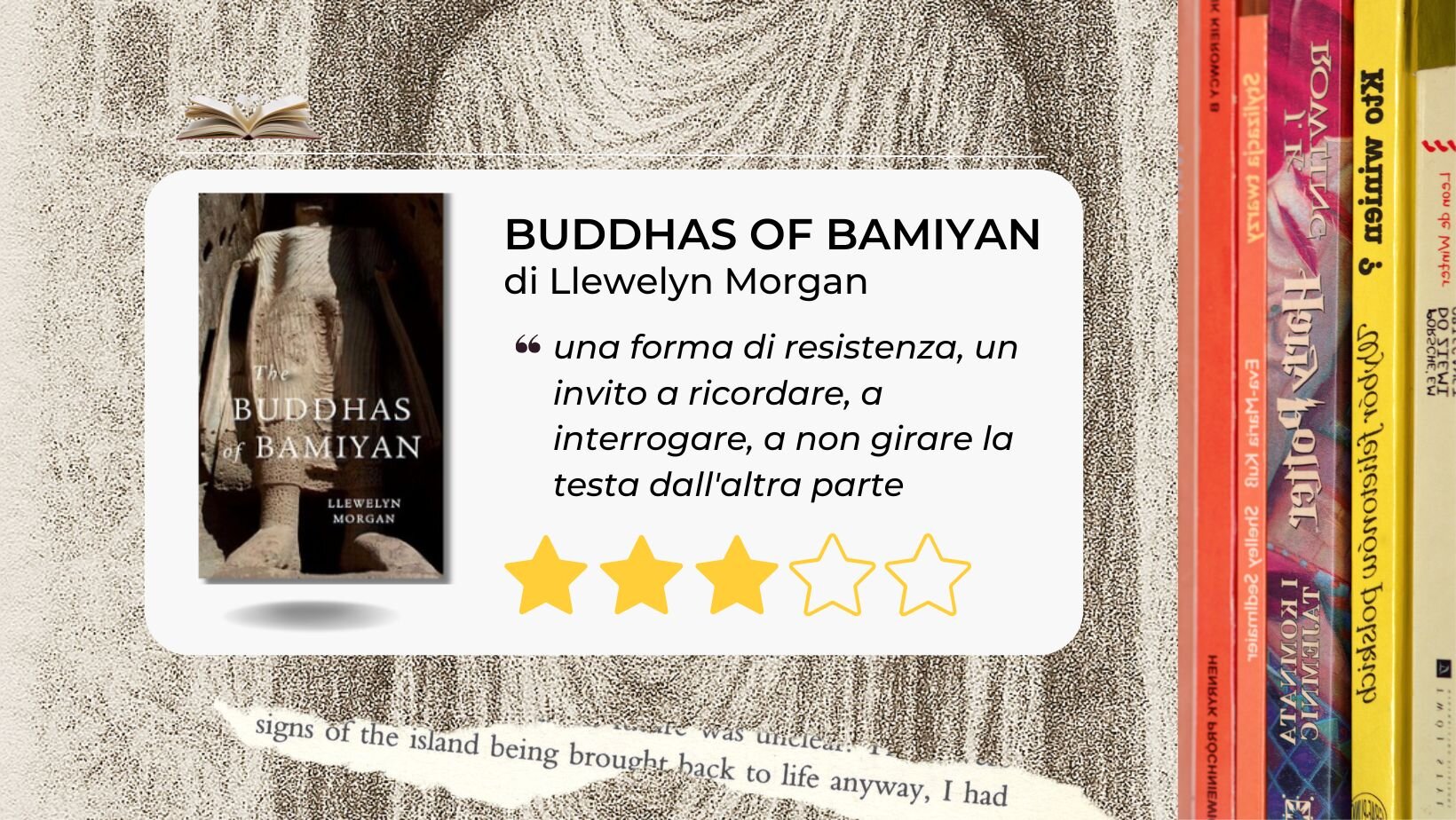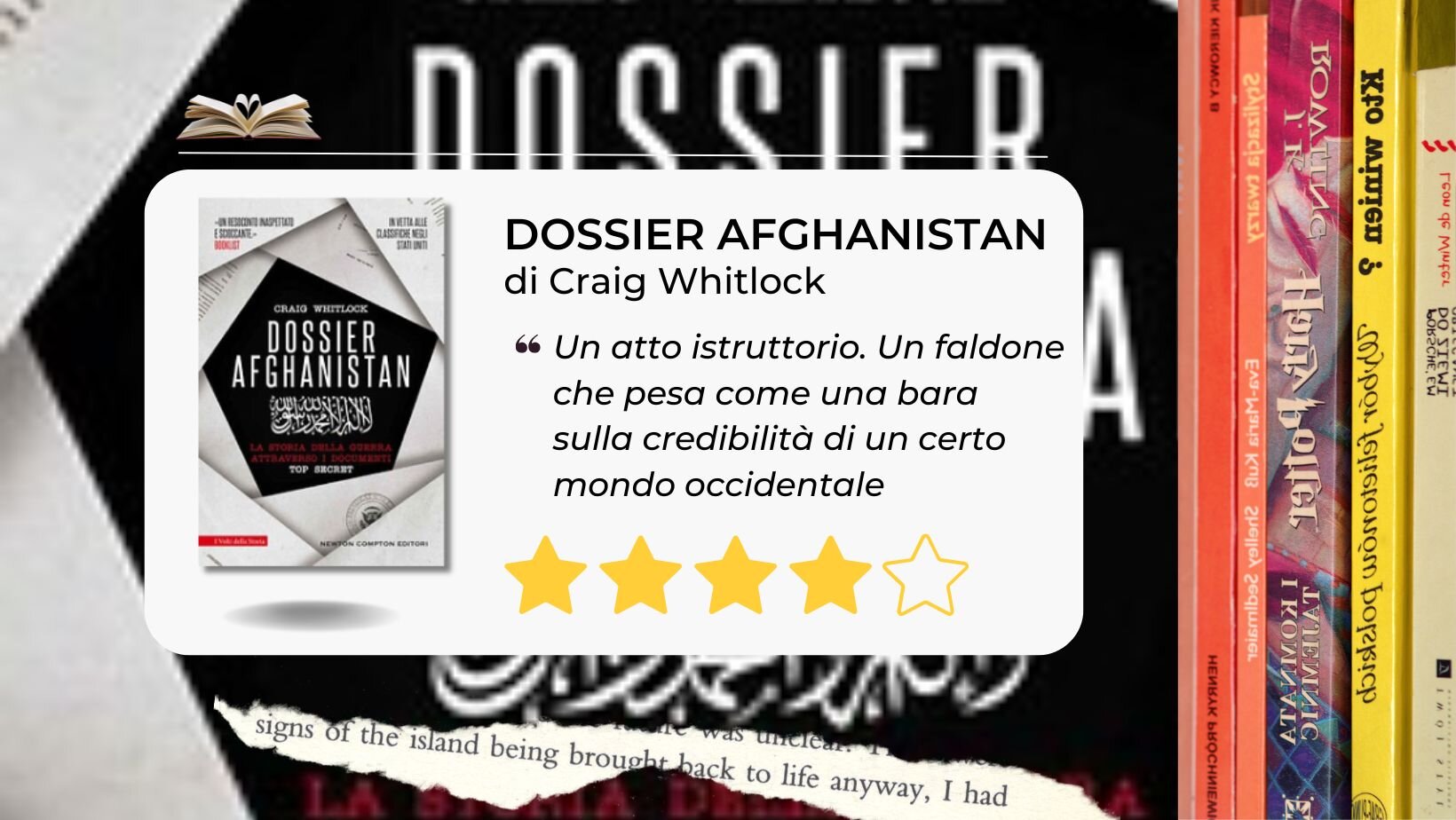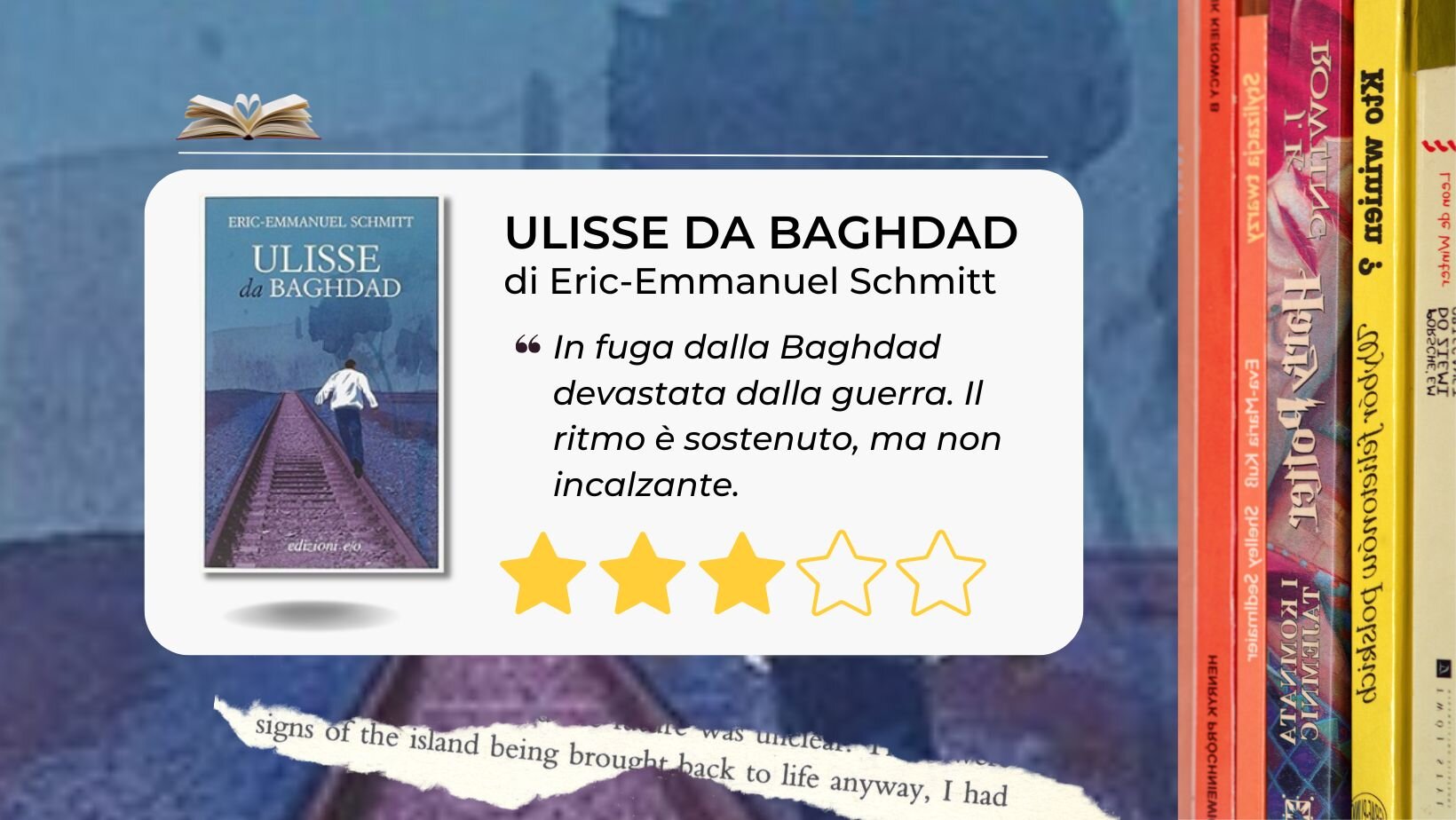Avvertenza
Valutazione e recensione sono frutto del mio personale gusto individuale, delle mie preferenze letterarie, così come la valutazione che assegno. E' quindi più che comprensibile, anzi auspicabile, che molti non la pensino come me. Detto ciò: ogni libro è fatto per essere letto.
⭐ Sufficiente
⭐ ⭐ Più che discreto
⭐ ⭐ ⭐ Buono
⭐ ⭐ ⭐ ⭐ Ottimo
⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ Eccellente
La mia valutazione su questo libro:
⭐ ⭐ ⭐ Buono
Ci sono romanzi che si leggono, e romanzi che si attraversano come vicoli bui, con il fiato corto e il passo incerto. "L’assassinio nel Vicolo della Luna" di Jarro, pseudonimo di Giulio Piccini, è uno di questi. Pubblicato nel 1883, ma ambientato nella Firenze del 1831 in piena epoca preunitaria, è considerato uno dei primi esempi di romanzo poliziesco italiano. Scritto ben cinque anni prima di “Uno studio in rosso” di Conan Doyle, è spesso appellato come “giallo”, ma l'aggettivo di genere suona stonato. Un po' perché il termine giallo associato ad un genere lettarario (esclusivamente italiano tra l'altro) ancora non era stato inventato, ma soprattutto perché nel caso di questo romanzo è riduttivo. "L’assassinio nel Vicolo della Luna" è molto di più: un affresco urbano, una denuncia sociale, un atto di memoria sporca.
Il vicolo della luna non è solo un luogo della Firenze che fu: è una crepa nella coscienza civile. Un uomo viene trovato accoltellato, e attorno a lui si muove una città che non cerca la verità, ma la quiete. La giustizia è un meccanismo che deve funzionare, non necessariamente funzionare bene. E in mezzo a tutto questo, c’è Lucertolo, il birro. Non un detective, non un eroe, è un poliziotto di strada, rude e spiccio, tutt’altro che geniale, ma che sa muoversi in una Firenze squallida, corrotta, violenta, assai lontana dai fasti rinascimentali. Una Toscana (perché i toscanismi nel fraseggio abbondano) che puzza di povertà e delazione.
Il suo nomignolo, Lucertolo, deriva da un taglio di carne toscano, a indicare il suo fisico imponente e la sua natura terragna. A lui Jarro dedicherà una quadrilogia, forse primo esempio di crime seriale nella letteratura popolare italiana. In fondo è un personaggio perfetto: un corpo che indaga, un pensiero che inciampa, un birro di quelli veri. La parola stessa, "birro", da cui deriva sbirro, ha radici antiche e brucianti. Viene dal latino tardo "birrus", che significa “rosso”, il colore della casacca indossata da certe guardie medievali e rinascimentali. Quella s, aggiunta a mo' di prefisso, ha poi trasformato il termine in sbirro, che nel tempo ha assunto una connotazione spregiativa: non più solo guardia, ma braccio armato del potere, strumento di repressione, figura ambigua. E Lucertolo incarna tutto questo: non è al servizio della giustizia, ma dell’ordine. E l’ordine, in certi contesti, è solo un altro nome per il silenzio.
Il lettore d'oggi, intendiamoci, ha bisogno di un poco di tempo per immergersi in un lessico arcaico, in un "italiano" di altri tempi, forse nemmeno così italiano. Jarro, infatti, scrive con una prosa densa, ottocentesca, a tratti melodrammatica, e per questo talvolta faticosa. Talvolta si ha l'impressione che un logopedista ci sarebbe d'aiuto per ricominciare a parlare in un passato che non ci appartiene. Ma sotto quella patina c’è una tensione che pulsa. Jarro non scrive per intrattenere: scrive per mostrare. E ciò che mostra è una Firenze che non si specchia nell’Arno, ma si nasconde nei suoi vicoli più sordidi. La Firenze che descrive non è quella dei salotti: è quella dei bordelli, delle osterie, dei vicoli che odorano di urina e paura. I personaggi sono scolpiti nel fango: prostitute, informatori, funzionari corrotti. La Firenze del 1831 è un teatro di ombre. Le strade sono sporche, le case cadenti, i personaggi ambigui. Il potere è opaco, la legge è arbitraria. E il lettore, come Lucertolo, deve imparare, pagina dopo pagina, a farsi largo tra le ambiguità, tra le voci che mentono, tra le nebbie del sospetto e le verità taciute o ignorate. E questo è divertimento puro.
Perché nella narrazione del Piccini nulla è ciò che sembra. Sin dall'inizio: il romanzo si apre con un grido. Ma non è quello dell’uomo accoltellato, bensì di una donna. Un urlo che squarcia la notte e che nessuno vuole davvero ascoltare. La polizia arriva, arresta, incastra. Ma la verità, come spesso accade, è altrove. Qui non serve la raffinata criminologia di Sherlock Holmes, non la psicologia sondante di Maigret. Serve un uomo che cammina, che osserva, che sbaglia. Che proprio per questo è credibile che fa camminare anche chi legge. E per camminare si cammina, ma non tanto per scoprire il colpevole, ma per capire quanto sia fragile il confine tra ordine e abuso, tra giustizia e vendetta. Non c’è redenzione, non c’è catarsi. E in questo, Jarro è più moderno di quanto sembri.
Un precursore certamente di ciò che sarà il noir made in Italy: dal "Vicolo della Luna" alla palude del Nordest, il noir italiano ha sempre avuto un’anima sporca e una coscienza vigile, non c’è investigazione brillante, ma un sistema marcio, una giustizia che inciampa, un potere che soffoca. Emilio De Marchi, pochi anni dopo, con "Il cappello del prete" (1888), affonda il coltello nella borghesia milanese, mostrando che il delitto non è devianza, ma riflesso sociale. E Massimo Carlotto, con "La verità dell’Alligatore" (1995), porta tutto questo nel presente: la corruzione è sistemica, la legge è ambigua, e il noir diventa l’unico linguaggio possibile per raccontare ciò che non si può dire.
Quando si chiude il libro, si ha la sensazione di aver camminato in una città che non ci appartiene, ma che ci riguarda. Di aver sentito il freddo del selciato, il peso del sospetto, il rumore sordo di una verità che nessuno vuole ascoltare. C'è la luna, ma non fa luce. Perché la luce, in questa Firenze, non è per tutti.