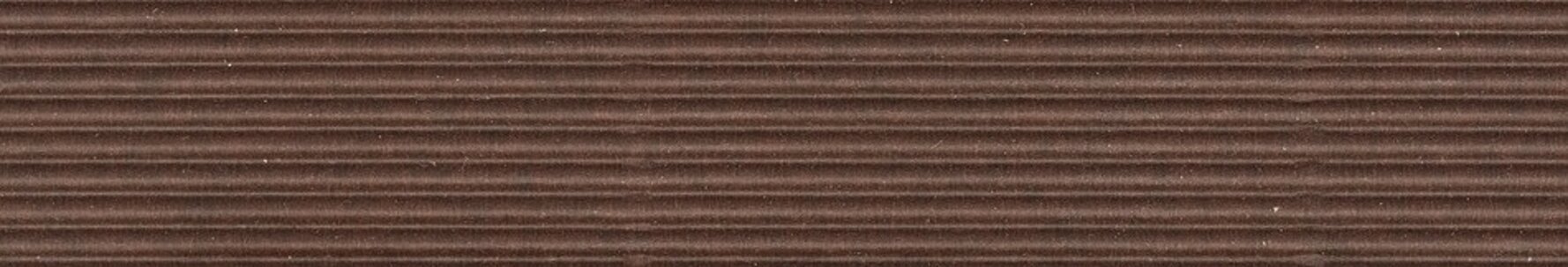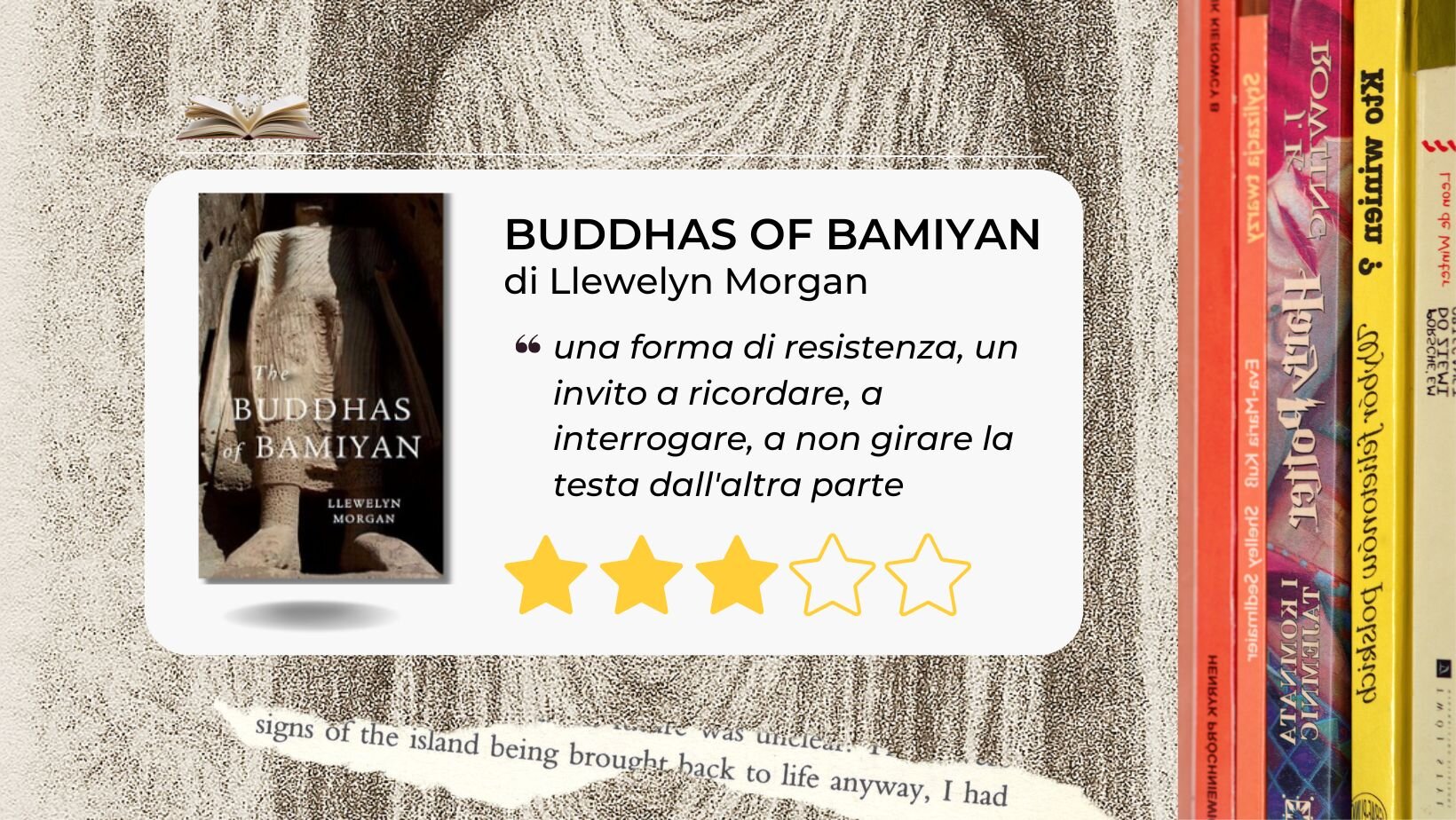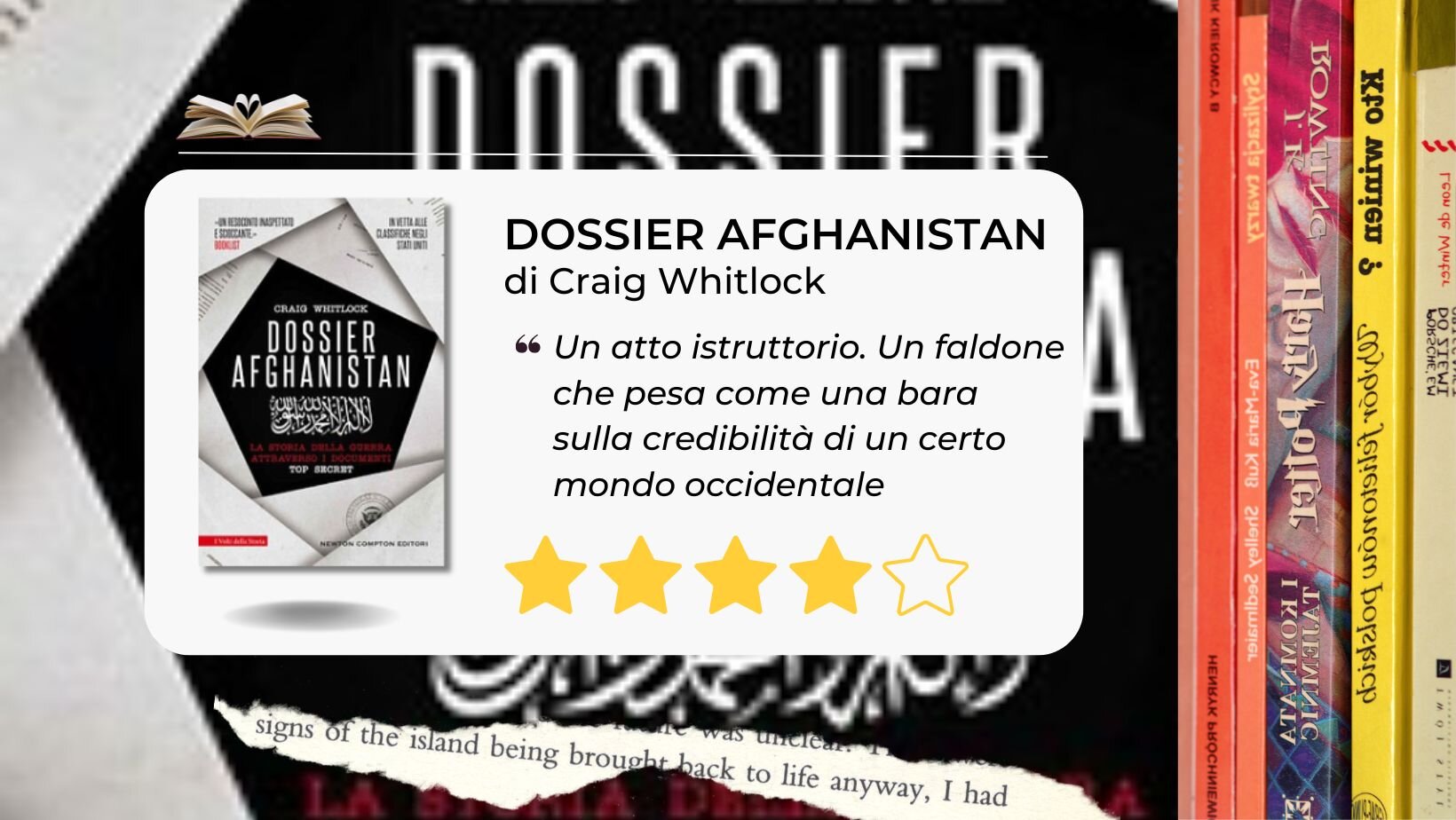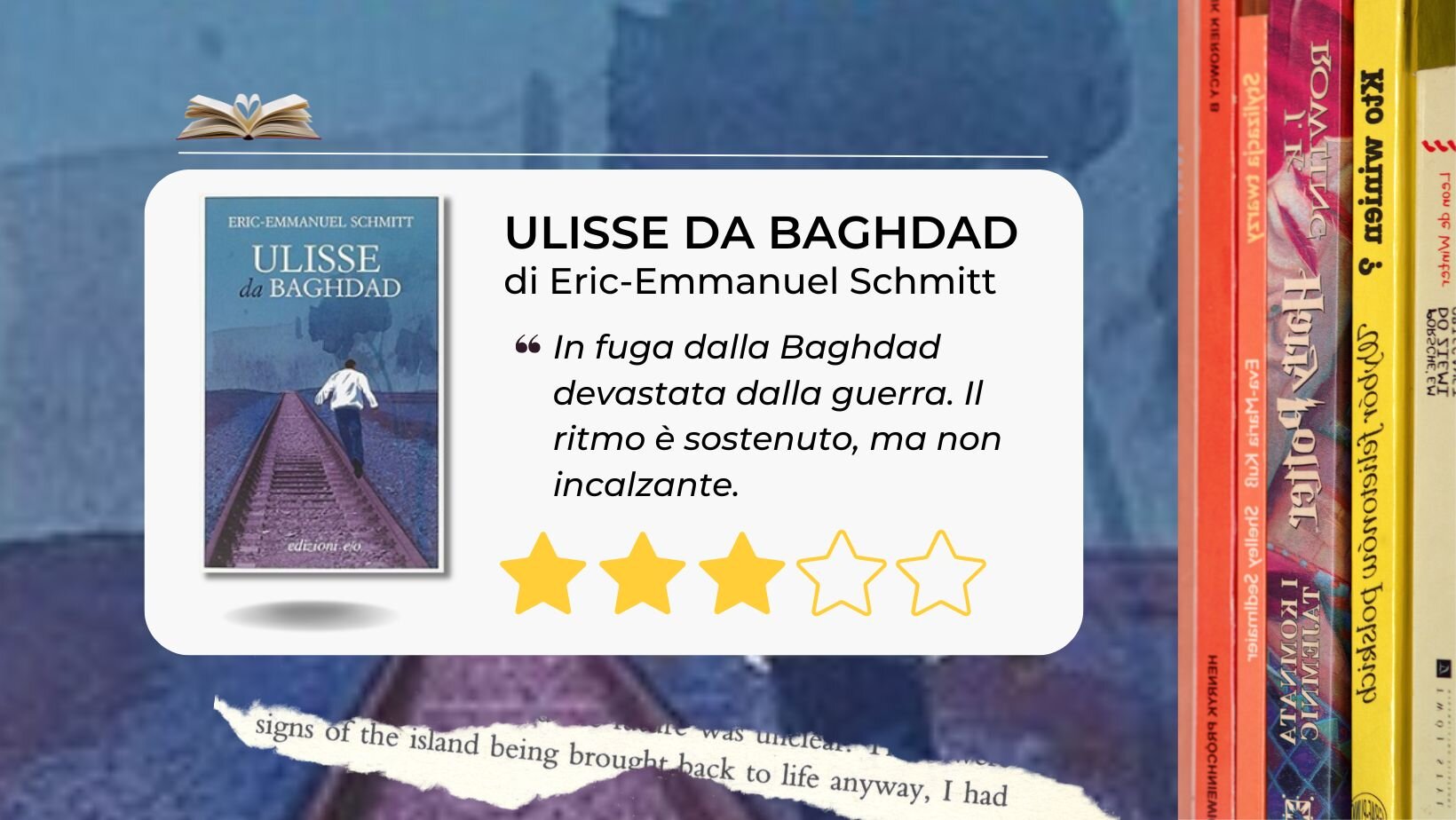Avvertenza
Valutazione e recensione sono frutto del mio personale gusto individuale, delle mie preferenze letterarie, così come la valutazione che assegno. E' quindi più che comprensibile, anzi auspicabile, che molti non la pensino come me. Detto ciò: ogni libro è fatto per essere letto.
⭐ Sufficiente
⭐ ⭐ Più che discreto
⭐ ⭐ ⭐ Buono
⭐ ⭐ ⭐ ⭐ Ottimo
⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ Eccellente
La mia valutazione su questo libro:
⭐ ⭐ ⭐ ⭐ Ottimo
I girasoli di Kiev di Erin Litteken non è un semplice romanzo: è una ferita che pulsa sotto la pelle della memoria. Un campo di girasoli che non profuma di estate, ma di resistenza. Di sopravvivenza. Di fame. Di paura e sguardi perduti nel nulla più profondo. La Litteken, storica americana di origini ucraine, non scrive per intrattenere: scrive per ricordare. Come hanno fatto Antonia Arslan con "La masseria delle allodole" o Susan Abulhawa in "Ogni mattina a Jenin".
Sono drammi diversi eppure simili, lontani tra loro eppure così vicini. La Litteken cuce gli eventi con una delicatezza che non addolcisce, ma amplifica e rende più tagliente il dolore. La sua penna scava nel terreno della Storia, e ciò che ne emerge è il Holodomor, il genocidio per fame orchestrato da Stalin tra il 1932 e il 1934, che sterminò milioni di ucraini. Un evento che il mondo ha dimenticato, ma che l’Ucraina porta ancora inciso nel proprio DNA. Conoscerlo rende più comprensibili in questo momento storico certe sfumature che affiorano tra i fumi e i miasmi della guerra con la Russia di Putin.
Il romanzo si muove su due binari temporali: da un lato, l’Ucraina degli anni ’30, dove Katya e Alina cercano rifugio in un fazzoletto di terra miracolosamente scampato alla collettivizzazione sovietica; dall’altro, l’Illinois contemporaneo, dove Cassie, giovane vedova, scopre il diario segreto della nonna Bobby, emigrata dopo la guerra. Due storie che si intrecciano come radici sotto la neve, unite da un filo invisibile: la necessità di dare voce a ciò che è stato taciuto.
Tra il 1932 e il 1933, l’Ucraina fu colpita da una carestia devastante, nota come Holodomor, che nel dizionario ucraino è sinonimo di “morte per fame”. Non piovve dal cielo come fa una calamità naturale, ma fu di una tragedia pianificata dalle politiche di collettivizzazione forzata imposte da Stalin. I contadini ucraini, storicamente legati alla terra e alla proprietà privata, furono costretti a cedere raccolti, bestiame e sementi allo Stato. Le quote di grano imposte erano talmente elevate da non lasciare nulla per la sopravvivenza al punto da obbligare le persone a brucare letteralmente l'erba. L’obiettivo di tutto ciò era più profondo: spezzare l’identità nazionale ucraina. Negli anni Venti, l’Ucraina godeva di una certa autonomia culturale e linguistica. Con l’ascesa di Stalin, questa autonomia fu sistematicamente smantellata. Le scuole ucraine furono russificate, gli intellettuali perseguitati, e ogni forma di nazionalismo repressa.
Ma se nell'olocausto armeno ad opera degli Ottomani l'arma fumante fu la deportazione, in Ucraina furono le leggi che vietavano la fuga dalle zone colpite dalla carestia organizzata e che punivano con la morte chiunque tentasse di nascondere il grano. Interi villaggi furono decimati. Secondo le stime (su cui ancora oggi è in corso un dibattito tra storia e statistica) morirono più di tre milioni di persone e c'è chi azzarda la drammatica cifra di sette milioni.
La Litteken, nel suo libro, non si limita a raccontare il dolore: lo incarna. Katya non è solo una vittima, è una testimone. E Cassie, nel presente, diventa il tramite attraverso cui quel testimone viene finalmente passato, in una drammatica staffetta familiare. Il diario, scritto in ucraino, è il cuore del romanzo: un cuore che pulsa piano, ma con costanza. I girasoli, simbolo ricorrente, non sono solo fiori: sono occhi rivolti al sole, anche quando il cielo è plumbeo. Sono il luogo segreto dove Katya e Alina trovano pace, dove la bellezza resiste alla barbarie. E sono anche il ponte tra generazioni, tra chi ha vissuto e chi deve ricordare.
La scrittura è semplice, ma capace di evitare banalizzazioni. La Litteken sa che la Storia non ha bisogno di orpelli: ha bisogno di verità. E la verità, qui, è scomoda. Tanto scomoda. È fatta di bambini che muoiono di fame, di madri che seppelliscono i propri figli, di silenzi imposti con la forza. Ma anche di amore, di speranza, di legami che sopravvivono al tempo e alla distanza. Questo romanzo è certamente un atto politico, nel senso più alto del termine. Non perché prende posizione, ma perché restituisce dignità a chi è stato cancellato. E lo fa non urlando vendetta, ma con rispetto, con una potenza che non ha bisogno di gridare.
Quando si chiude il libro, non si ha la sensazione di aver letto una storia. Si ha la certezza di aver ascoltato una voce. Una voce che viene da lontano, ma che parla chiaro. E che ci chiede, semplicemente, di non dimenticare. Di fare come i girasoli di Kiev che sono fiori fragili, esposti, ma che guardano sempre alla luce. Anche quando la luce sembra non esserci più.